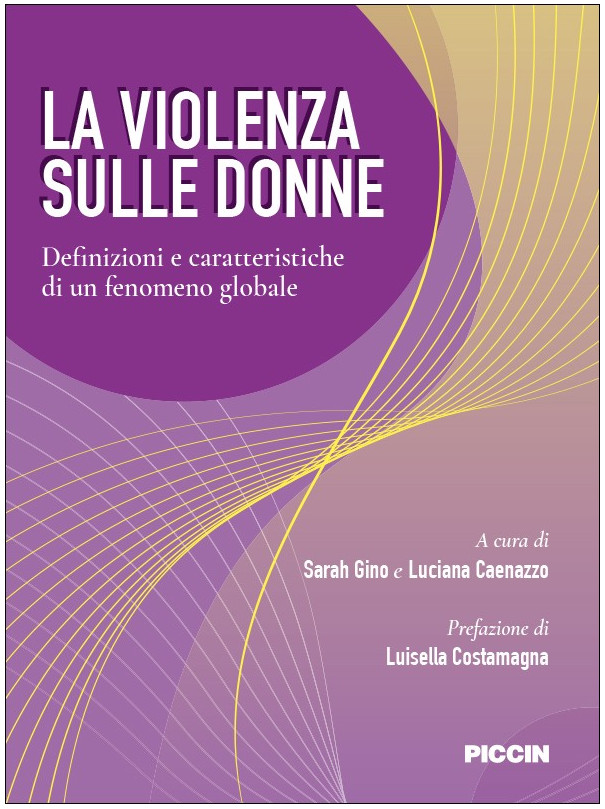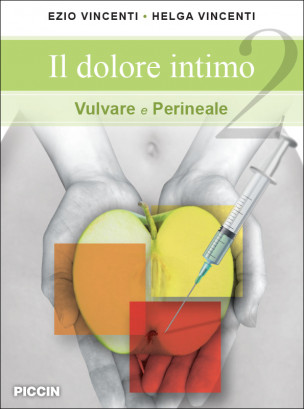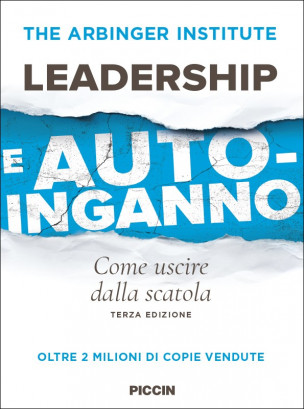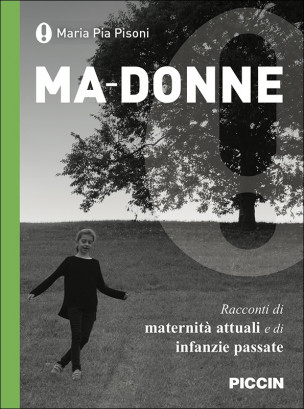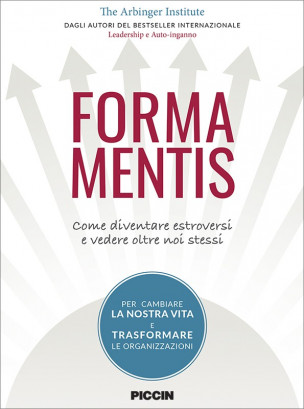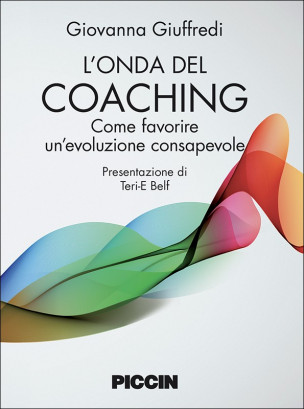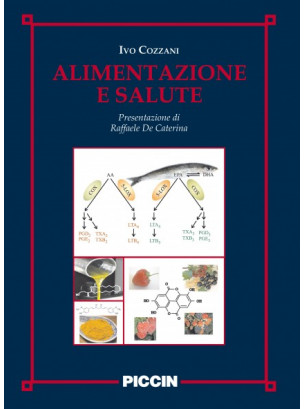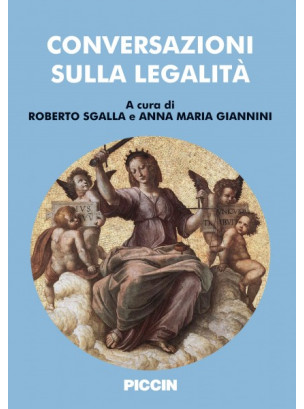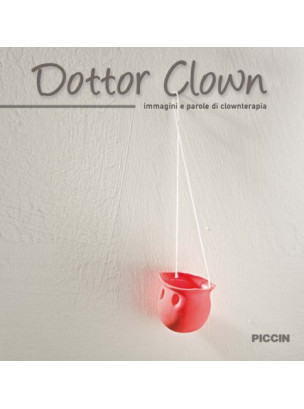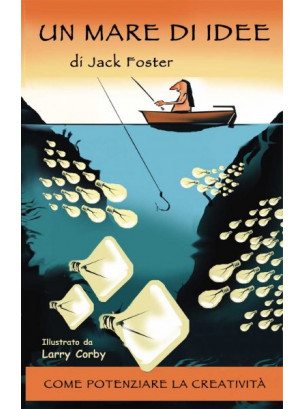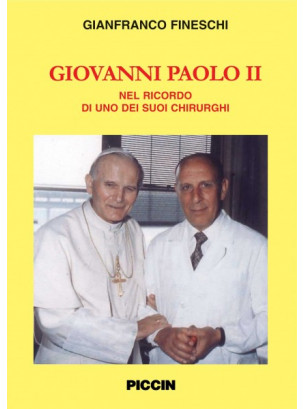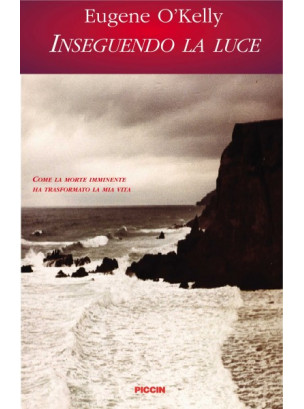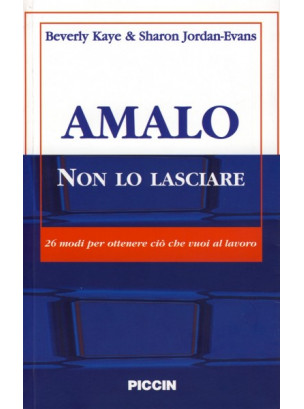LA VIOLENZA SULLE DONNE - Definizioni e caratteristiche di un fenomeno globale
Sarah Gino - Luciana Caenazzo
13,00 €
PREFAZIONE
Qualcosa è cambiato? Qualcosa sta cambiando?
La domanda non è soltanto legittima (come lo sono tutte le domande): è inevitabile, addirittura necessaria. Perché sarebbe singolare, per non dire inaccettabile, che a un anno di distanza dall’esplosione del movimento Me Too, dopo polemiche, appelli, discussioni, scontri, bordate sui social, ore e ore di talk show, dovessimo guardarci intorno, scuotere il capo e dire rassegnate “non è cambiato nulla”. Dall’ottobre 2017, ossia da quando per la prima volta il produttore americano Harvey Weinstein – uno degli uomini più potenti di Hollywood dunque del mondo – è stato pubblicamente accusato di violenza sessuale, il Me Too è stato sulla bocca di tutte e tutti: non c’è probabilmente nessuno che non abbia espresso almeno una volta la propria opinione sul tema, non abbia disquisito sulle differenze tra violenza e molestia, sui confini del corteggiamento, sui tempi e le difficoltà delle denunce, sui rapporti di potere nei luoghi di lavoro. Abbiamo discusso, preso posizione, fatto le nostre distinzioni sentendoci parte di uno stesso tutto che andava dalla star del cinema a noi comuni mortali, dalla studiosa che denunciava il problema da anni alla giovane donna che aveva appena cominciato a esplorarne i confini. Le parole sono state senza ombra di dubbio smosse. E le coscienze?
La violenza di genere è una piaga lancinante, un’indiscussa emergenza, un comportamento ripugnante, un reato da sanzionare severamente. Nessuno oserebbe mai mettere in discussione queste affermazioni, neppure nel Paese in cui fino a un ventennio fa – fino alla legge 66 del 15 febbraio 1996 che la trasformò in reato contro la persona – la violenza sessuale era rubricata dal codice penale come “delitto contro la moralità pubblica e il buon costume” (tradotto: se costringi una donna a fare sesso contro la sua volontà danneggi i costumi, non lei). Insomma, nonostante il nostro sofferto e complicato iter legislativo (molto ben spiegato nelle pagine che seguono) la condanna contro la violenza di genere è ormai unanime. Ma quando cerchiamo di capire perché – ancora – gli uomini violentino, abusino, molestino, ecco che i contorni della questione cominciano a farsi nebulosi, le certezze si indeboliscono, tutto si complica. Se domandate a un uomo che sta esercitando pressione psicologica sulla moglie o compagna – con scuse standard tipo che “la ama troppo”, che “la gelosia è parte integrante dell’amore” e via farneticando – cosa pensi della violenza contro le donne, vi dirà sicuramente che la condanna. Che è una cosa orribile. E continuerà a ripeterlo anche dopo il primo ceffone. Perché lui no, lui non è come quelli, lui è solo un uomo che ama alla follia, che ha buoni motivi per alzare la voce, e comunque è stato un momento e non succederà più. Promesso.
Invece, come sappiamo, succederà ancora. E allora il punto – come sempre – non è osservare la cima dell’iceberg, che è sempre illuminata; ma andare sotto. Indagare la base.
Cominciamo da un dato. Secondo l’“Indice della criminalità” 2018, elaborazione del “Sole 24 Ore” sui dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno, il 2017 ha visto i crimini “emersi” (ossia denunciati) complessivamente in calo del 2,3%. Una buona notizia, che contraddice la diffusa percezione di insicurezza intorno alla quale ruota – spesso strumentalizzandola – buona parte del nostro dibattito politico. Ma c’è un ma. Le violenze sessuali sono in controtendenza. Crescono. Le denunce sono state in media quasi 13 al giorno, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. È vero: si tratta – ripeto – di reati denunciati, dunque il dato potrebbe essere paradossalmente interpretato in positivo, ossia come segnale che si denuncia di più, magari proprio sulla scia dell’ondata di sdegno legata al Me Too. Ma va ribadito che il movimento è nato in ottobre, dunque il lasso di tempo in cui può avere spinto le donne a uscire maggiormente allo scoperto, a vincere quella terribile vergogna che per anni ha paralizzato le vittime e aiutato i carnefici a restare impuniti, è alquanto limitato. E, comunque sia, anche ammesso che si denunci di più e quindi il fenomeno non sia in crescita, la cifra di 4634 episodi di violenza di genere in un anno è semplicemente intollerabile. È il segno evidentemente di un baco, un virus che ci contagia senza che nessuno si stia preoccupando davvero di trovare la cura.
Anni fa ho trascorso un periodo in un centro antiviolenza, in compagnia di donne che fuggivano (spesso in compagnia dei figli) da situazioni drammatiche, potenzialmente letali, e di volontarie che – in una condizione di cronica ristrettezza di mezzi e risorse – si spendevano per cercare di restituirle alla vita. Da quella esperienza è nato un reportage, Parole come ferite, che andò in onda su Rai3, e un’amicizia. Bruna era una donna abusata che aveva trovato il coraggio di uscire dalla sua prigionia e, alla fine del percorso, era diventata operatrice del centro. Da lei, dalla sua intelligenza e dalla sua energia ho imparato un mare di cose. Per esempio, che il primo passo che una vittima di una situazione di violenza deve fare, forse il più difficile, è riconoscere la violenza (quasi un terzo delle italiane vittime di violenza domestica, ossia 550.000 donne, ci dice Save the Children sulla base di dati Istat, non denunciano né si rivolgono a medici, e nel 57% dei casi non considerano la violenza subita un reato, ma solo “qualcosa di sbagliato”); che sottrarsi alla violenza non significa soltanto salvare se stesse, ma molto spesso anche i propri figli, preservandoli da conseguenze devastanti (quasi la metà delle violenze domestiche – sempre secondo Save the Children e Istat – avvengono sotto gli occhi di minori, e i medici e operatori concordano nell’affermare che per loro assistere alla violenza è come subirla direttamente); e che uno dei motivi per cui molte donne non riescono ad abbandonare un uomo violento e andarsene, anche quando hanno preso coscienza del pericolo in cui si trovano, è che non hanno indipendenza economica. Da sole non saprebbero come vivere.
Ecco: la violenza non è semplicemente il momento della percossa o della costrizione sessuale. La violenza è, sempre e comunque, un’acqua in cui si è immersi. Un contesto fatto di valenze simboliche ed esigenze pratiche, di modo in cui siamo viste e di modo in cui vediamo noi stesse, di cultura e di retaggi vecchi come il mondo. La violenza è sempre un punto di arrivo. Per questo è necessario agire sulle premesse.
Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea, ha sviluppato un indicatore – Gender overall earnings gap – che determina l’effetto di tre fattori (guadagno orario, ore retribuite e tasso di occupazione) sulla differenza di reddito medio di uomini e donne in età lavorativa. Secondo l’istituto, nel nostro Paese tale divario è del 43,7, contro il 39,6 dell’Unione europea. In breve: se un uomo guadagna 100, una donna guadagna poco più di 60.
Dati sostanzialmente confermati dal rapporto Oxfam 2017 sul lavoro femminile nell’Ue, secondo cui, in media, nei 28 Paesi membri dell’Unione le donne devono lavorare 59 giorni in più l’anno per essere retribuite quanto gli uomini. Quanto all’Italia, la ricerca del Word Economic Forum sul Global Gender Gap Index, la differenza di tasso di partecipazione economica tra uomini e donne, parla chiaro: siamo al 118° posto su 142 paesi censiti. Sconfortante.
Qualcuno dirà: perché parli di soldi se il tema di partenza era la violenza di genere? Semplice. Perché se vogliamo risolvere un problema, dobbiamo prima comprenderlo. E, per quanto la valutazione economica delle persone non sia tutto, è sicuramente significativa. Se le donne sono pagate meno degli uomini, e non solo non c’è una ragione che giustifichi questo squilibrio, ma pochissimi sembrano considerarlo una priorità, è evidente che c’è un problema di visione. Sotto sotto, c’è l’idea che tutto sommato il lavoro maschile sia più normale, più naturale, più “giusto” del lavoro femminile. Che le donne lavorino per gentile concessione, e dunque non possano pretendere più di tanto. “Già lavori, vuoi pure essere pagata come me?”.
È un segno. Fondamentale. E non è certo l’unico. Se si accetta pacificamente che la donna sia sminuita sul lavoro, perché mai non dovrebbe essere umiliata in altri contesti? Se una cultura non considera questo squilibrio come un vulnus inaccettabile, ma anzi lo alimenta, perché poi dovremmo stupirci di casi evidenti o carsici di victim blaming (il paradosso per cui spesso, nei casi di violenza di genere, la situazione si ribalta e a essere messa sotto accusa è la vittima, magari per una gonna “troppo corta” o perché la donna non è sufficientemente “retta”, ecc.), come quando un grande nazionale titolò “Marina la scuola con i compagni: stuprata nei bagni della stazione”. Quasi che lo stupro fosse la punizione per un comportamento “negativo”, e non esclusivamente l’atto ripugnante di un criminale. Quasi che si volesse far echeggiare un giudizio: ripugnante, sì, ma se non avesse marinato la scuola… Insomma un po’, classicamente, “se l’è cercata”. Se viene considerato normale l’uso strumentale e propagandistico dell’informazione, per cui – per esempio – si dà ampio spazio se gli stupratori sono stranieri e la vittima italiana e si “dimentica” la notizia nel caso di un episodio uguale ma a parti invertite, o un politico afferma che una violenza è “più grave” se commessa da migranti, allora evidentemente qualcosa non funziona. Uno stupro è uno stupro. Non c’è nulla – nazionalità, colore della pelle, presunte intenzioni, rapporti di familiarità, condizione della vittima – nulla che possa modificare la sua essenza di atto ripugnante e distruttivo. Punto.
È questione di cultura. Cioè di visione del mondo. Fintantoché cederemo anche solo di un millimetro su questo terreno, fintantoché vergogna, inferiorità (oggettivamente imposta o soggettivamente percepita), senso di colpa, differenza saranno parte integrante, anche infinitesimale, del DNA femminile, non potremo sperare di contrastare efficacemente la piaga della violenza. Finché le donne – beninteso se lo meritano – non guadagneranno quanto gli uomini, non occuperanno eguali cariche istituzionali, non saranno in parità nei consigli di amministrazione delle imprese, nelle direzioni di giornali e telegiornali, alla testa di aziende sanitarie e di autorità di garanzia, nei tribunali (e l’elenco potrebbe continuare a lungo), i pilastri culturali su cui attecchisce la violenza rimarranno solidi e inattaccabili.
Ecco perché questo è un libro importante: perché affronta il problema con uno spirito multidisciplinare che è l’unico che possa portare risultati. Sviscerare il tema in tutti i suoi aspetti per poterlo comprendere e comunicare è l’unica speranza che abbiamo di cambiare un modo di pensare radicato da tempo immemorabile, e di cui tutti (e tutte) siamo vittime, volenti o nolenti, consapevoli o inconsapevoli. Soltanto mettendo a rete interventi legislativi mirati, informazione, prevenzione, repressione, istruzione e studio scientifico (per esempio delle conseguenze devastanti a medio e lungo termine della violenza, così vividamente descritte nelle pagine che seguono) si potrà incidere davvero. E finalmente rispondere con convinzione: sì, qualcosa è cambiato. Questo libro è un passo sulla strada giusta.
Luisella Costamagna
No customer comments for the moment.